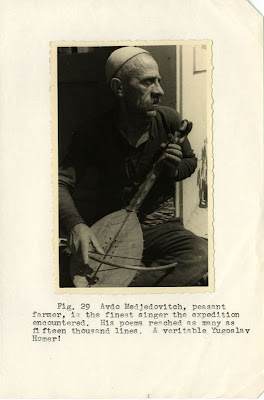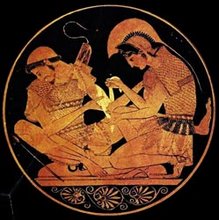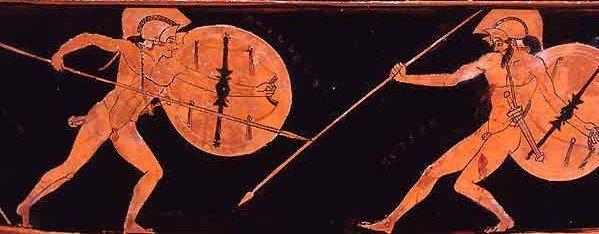Heinrich Schliemann (4)
Molti allora pensavano che Troia sorgesse su un’altura che domina il villaggio di Pinarbasi. Arrivato sul posto, Schliemann scrive: “Potei appena dominare la mia emozione di fronte all’immensa pianura di Troia, la cui immagine aveva popolato i sogni della mia infanzia. Tuttavia, a prima vista, mi parve troppo lunga e Troia troppo distante dal mare”.
Omero era la bibbia di Schliemann. Per lui era assolutamente escluso che i cenni topografici contenuti nell’Iliade e nell’Odissea fossero falsi. Ora, nell’Iliade appunto, greci e troiani, combattendo, si spostavano spesso, anche più volte in una sola giornata, dalla città di Priamo al luogo dove erano ancorate le navi. Quindi Troia doveva trovarsi più vicino alla costa. D’altronde, come avrebbe potutto Achille, inseguendo Ettore, fare tre volte di corsa il giro di questa collina e salire sul pendio scosceso al di là del corso dello Scamandro?
Bisognava cercare Troia altrove. L’antica città di Priamo non poteva sorgere sulle alture che dominavano il paese di Pinarbasi.
Ad appena un’ora di strada dall’Ellesponto sorge la collina di Hissarlik, l’ultimo promontorio dell’altopiano. È la collina più vicina al mare, che divide i corsi dello Scamandro e del Simoenta, esattamente come viene narrato dall’autore dell’Iliade. Lì doveva sorgere la città di Priamo e lì avrebbe scavato Schliemann!
L’11 ottobre 1871, avendo ottenuto il permesso dal governo turco, grazie in particolare all’intervento dell’ambasciata americana a Costantinopoli, Schliemann comincia la prima delle sue numerose campagne di scavi a Hissarlik. Tra il 1871 e il 1873 lavorerà per un totale di undici mesi sulla collina, aiutato dalla moglie Sofia, un’ateniese che è a sua volta appassionata lettrice di Omero, e da una squadra di cento-centocinquanta operai diretti da tre capomastri. Sofia Schliemann invece dirige una squadra di una trentina di operai.
L’epilogo è noto: sulla collina di Hissarlik Schliemann scoprì i resti della città di Troia, le porte Scee e il tesoro di Priamo. Il suo entusiasmo e la sua perseveranza aprivano un nuovo capitolo di storia: era nata l’archeologia omerica.